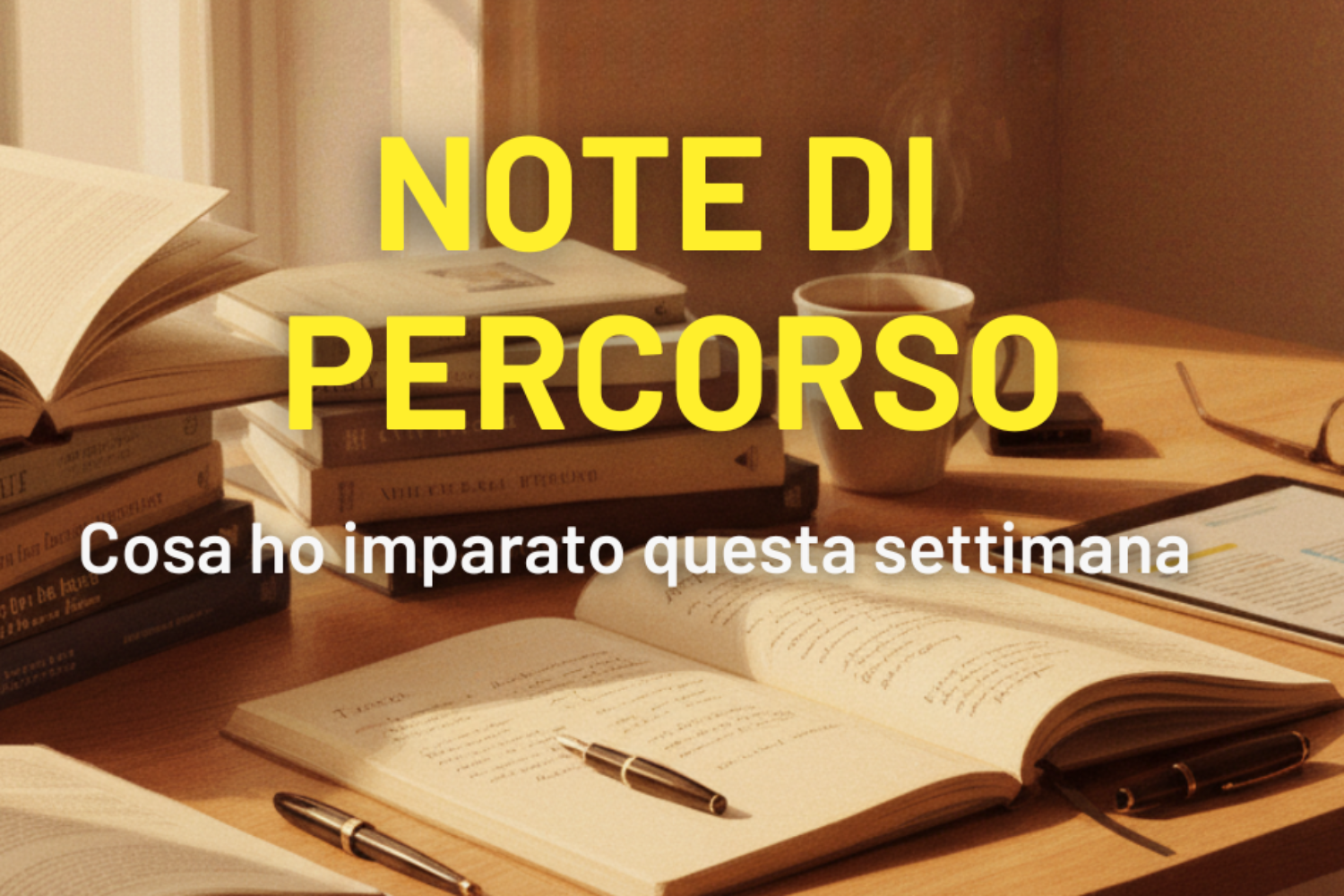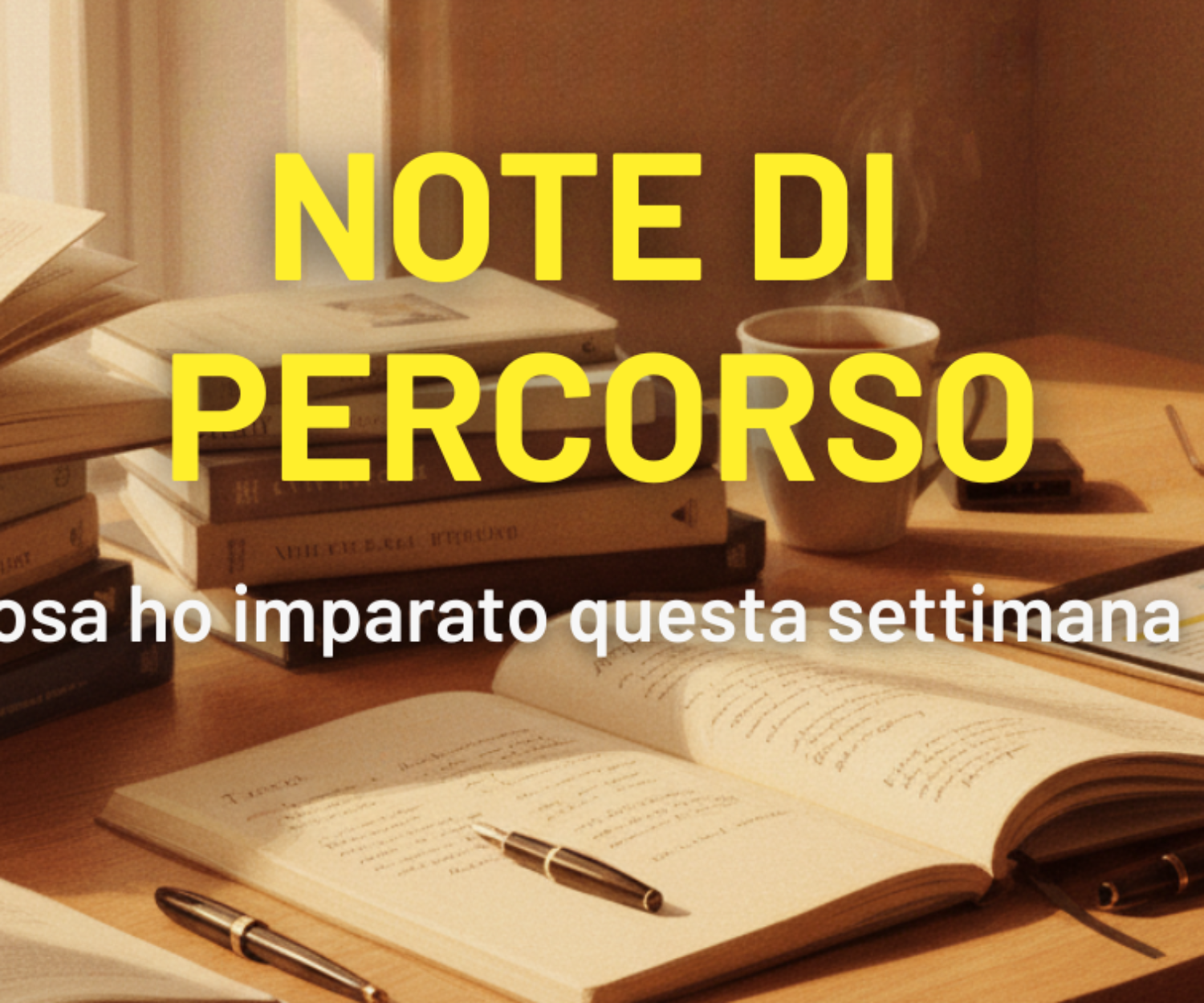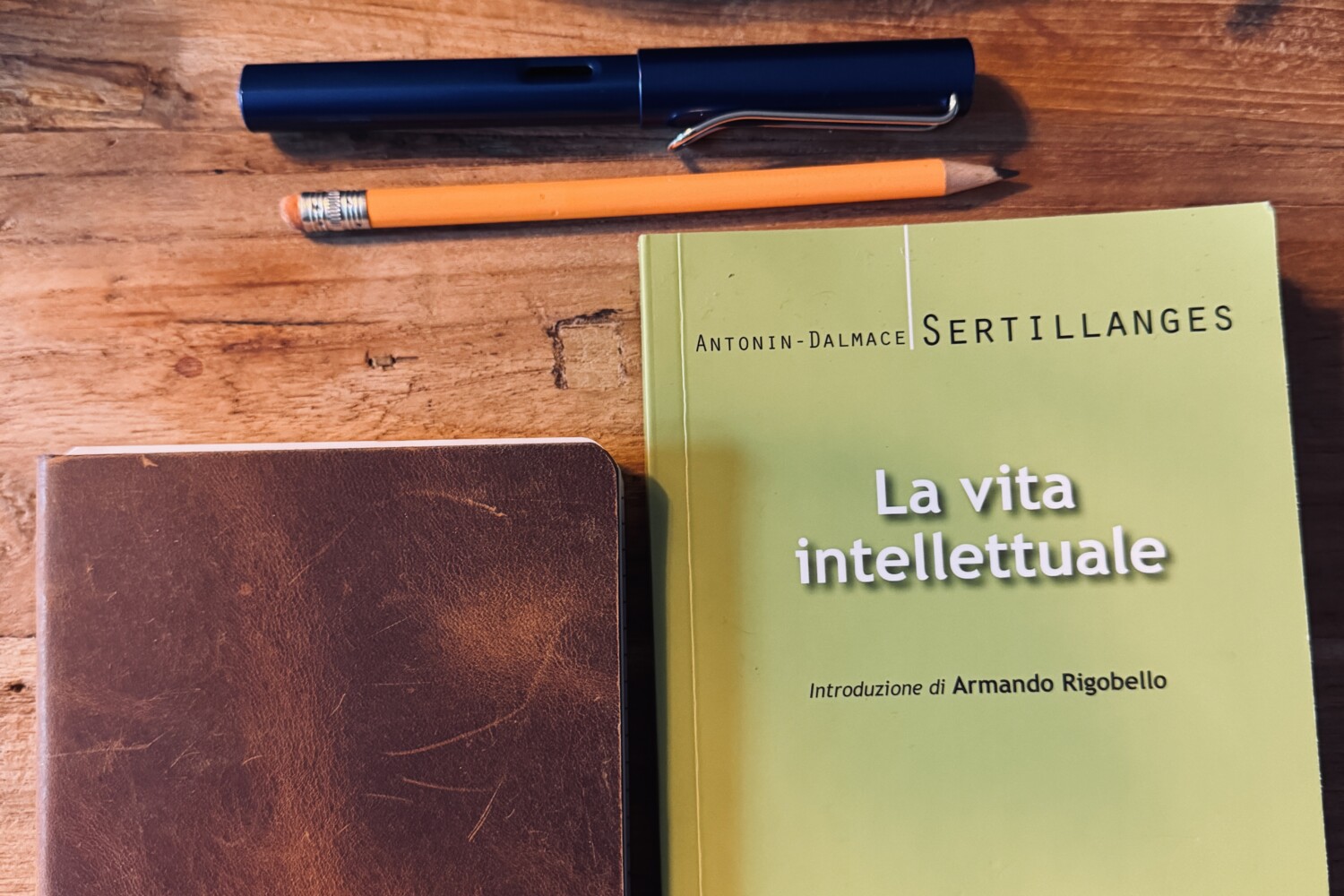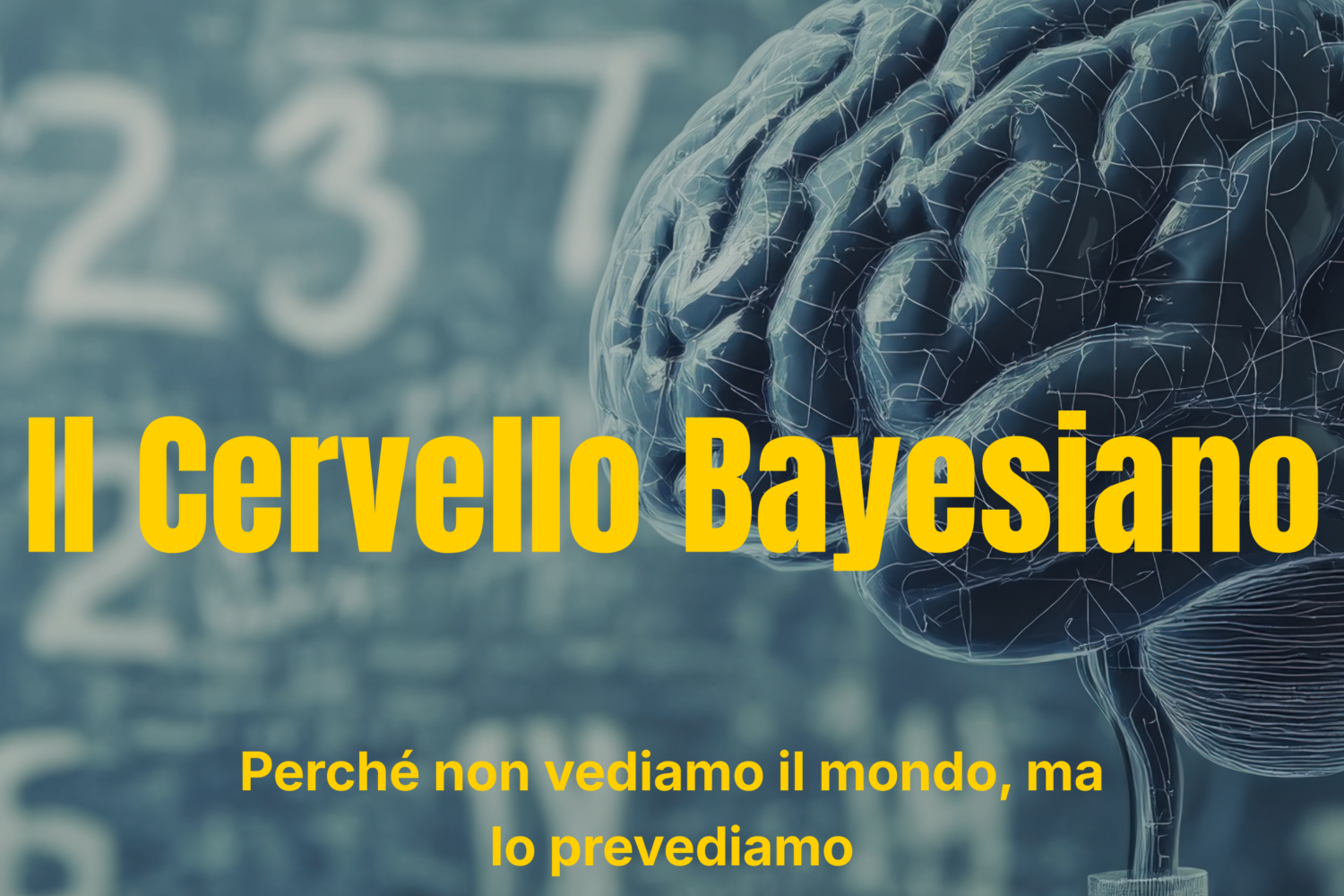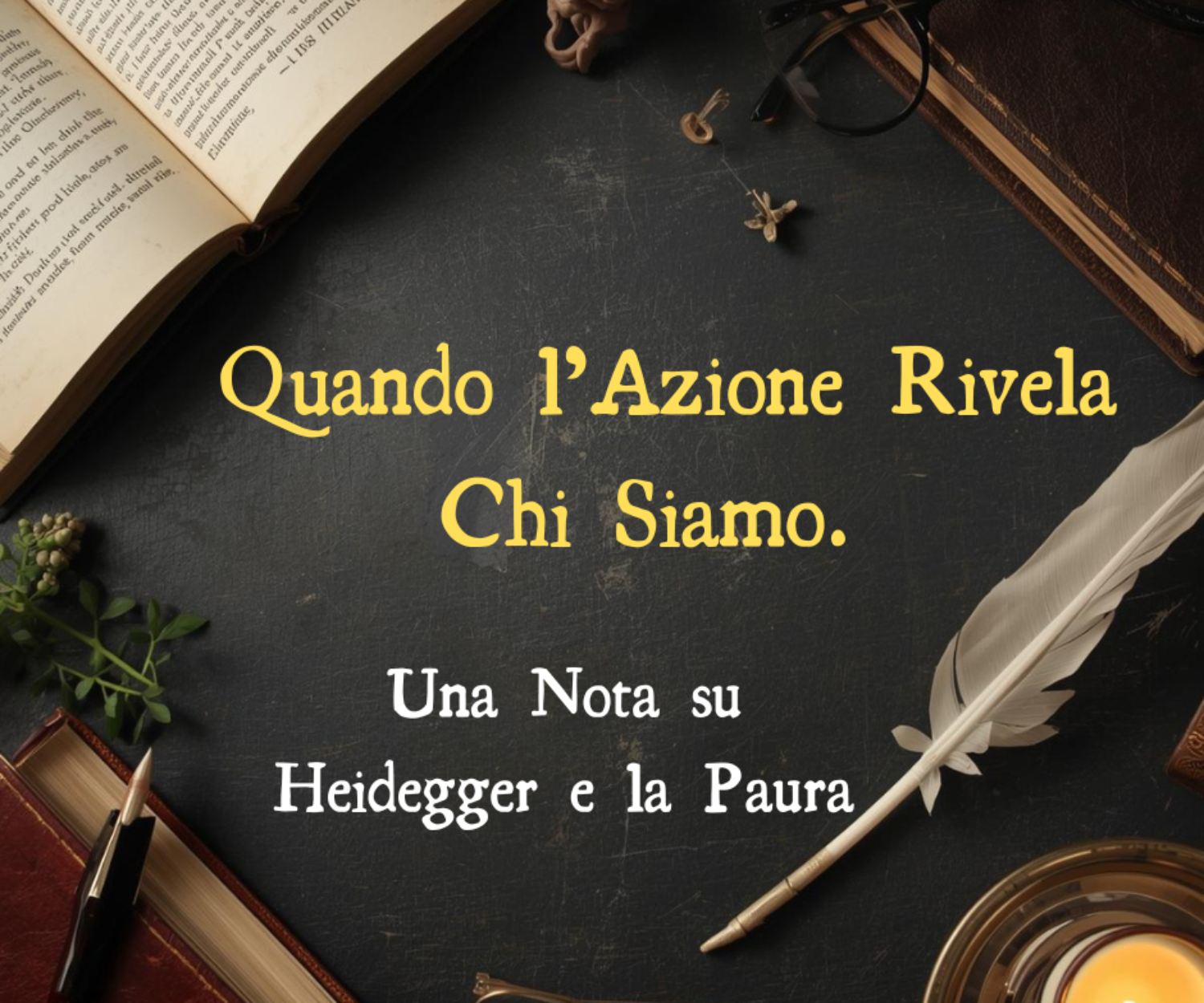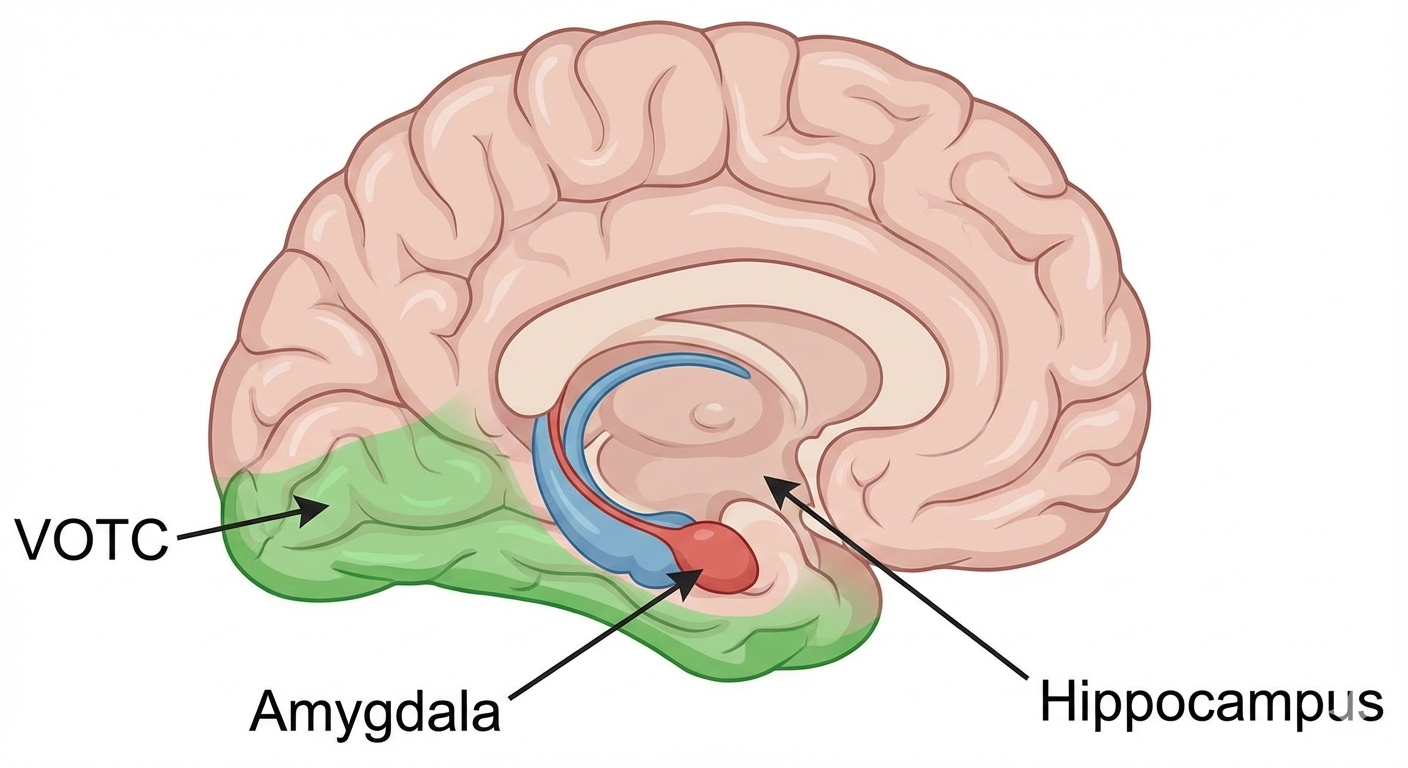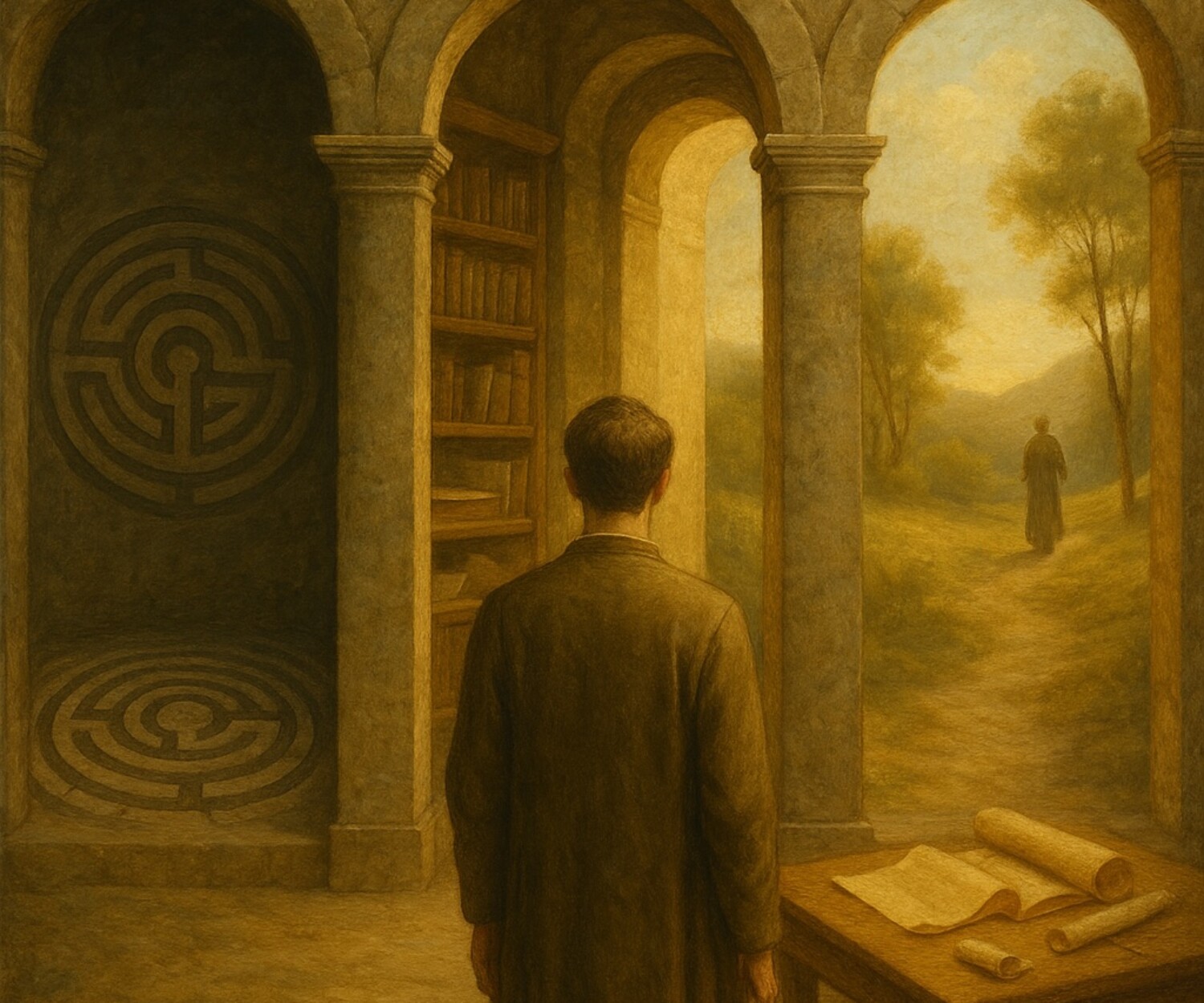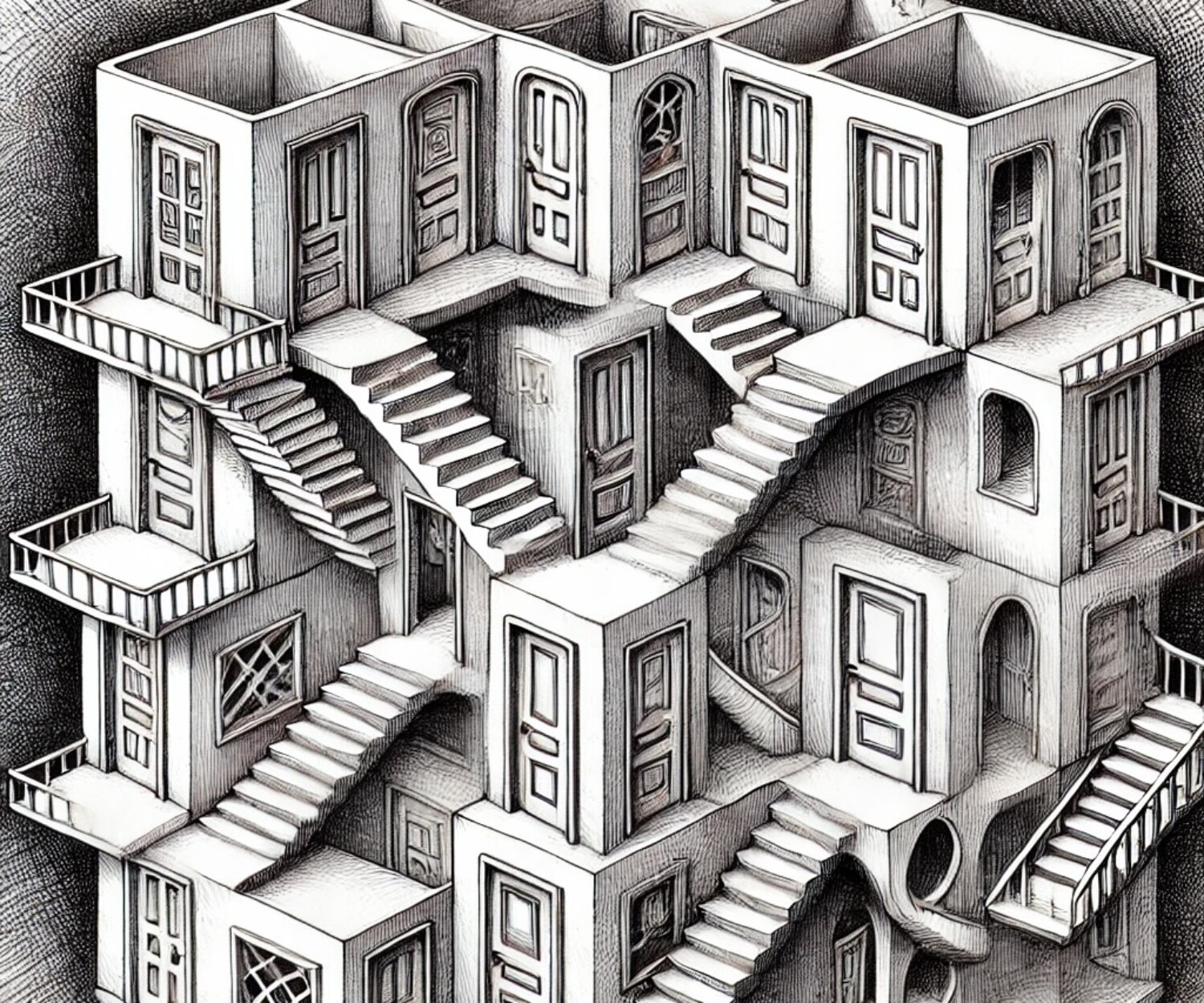Questa settimana ho avuto una conferma: quella strana sensazione di “corsa a vuoto” che proviamo ogni tanto non è un malfunzionamento, ma un segnale di maturazione.
Oltre la linea del traguardo (Attività Ateliche)
Rileggendo alcune note nel mio “secondo cervello”, ho ritrovato una riflessione sul passaggio tra attività teliche (orientate a uno scopo) e ateliche (dove il valore è nel processo). Nei primi trent’anni di vita è facile saltare da un obiettivo all’altro senza sosta. Poi, però, iniziamo a sentire il peso di questo eterno correre. Ci rendiamo conto che la felicità non è mai “dietro il prossimo traguardo”. La svolta avviene quando il processo diventa più importante del risultato. Paradossalmente, è proprio quando smettiamo di ossessionarci per l’obiettivo che i risultati superano le aspettative. Come diceva Hunter S. Thompson, non si tratta di trovare un obiettivo, ma di trovare un modo di vivere che ci permetta di essere noi stessi.
Il “Metodo Oxford” e il valore della lentezza
Cercando un modo per nutrire questa creatività “senza scopo finale”, mi sono imbattuto nel sistema di studio di Oxford. Mi ha affascinato il rapporto uno-a-uno tra tutor e studente: ogni settimana un saggio, una domanda precisa e una discussione serrata per scovare ogni debolezza logica. Mi ha ricordato quanto sia vitale oggi recuperare il Trivio (grammatica, logica, retorica) per non naufragare nelle opinioni frammentate.
Il pilastro di tutto questo è la lettura analitica. Oggi leggere lentamente è visto come una perdita di tempo. Eppure, è solo leggendo poche pagine al giorno, rileggendole e abitandole, che entriamo davvero in comunione con l’autore. Le parole sono portatrici di memoria (filologia); se le consumiamo velocemente, ne assorbiamo solo una piccola parte. In un’era che demolisce la concentrazione, prendersi il tempo per “perdere tempo” davanti a un libro di 200 anni fa è un atto di ribellione.
L’illusione del Sé
Questa ricerca di profondità si è intrecciata con un articolo di Maria Popova sul “Senso del sé”. Lei definisce il Sé come “la storia del perché tu sei tu”. Un’illusione creata dalla memoria per darci un senso di continuità in un universo dominato dal caso.
Sono ormai tre anni che pratico la meditazione non-duale grazie a Sam Harris, ed è stato un punto di svolta. Quando senti “sulla tua pelle” l’inconsistenza dell’ego, la compassione per gli altri aumenta automaticamente. Si fa spazio a quello che Elias Amidon chiama “il primo momento”: quell’istante millimetrico tra l’attimo che muore e quello che nasce. È lo spazio in cui, per i Sufi, possiamo finalmente incontrare Dio.
Tra Pascal e Leopardi: lo stupore di esserci
Questo flusso di pensieri mi ha portato a rileggere Pascal e Leopardi. C’è una strana bellezza nell’angoscia che proviamo davanti all’infinito.
“Quando considero la breve durata della mia vita, assorbita nell’eternità che la precede e la segue, il piccolo spazio che occupo e che vedo, inabissato nell’infinita immensità degli spazi che ignoro e che mi ignorano, io spaurisco e mi stupisco di vedermi qui piuttosto che là, perché non c’è ragione perché qui piuttosto che là, perché adesso piuttosto che allora.”
È la stessa sensazione che prova Leopardi davanti ai “sovrumani silenzi”:
“Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
Io nel pensier mi fingo; over per poco
il cor non si spaura. E come il vento
Odo stormir tra quelle piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce
Vo’ comparando: e mi sovvien l’eterno.”
Questa non è depressione, è la pura natura umana che si risveglia. Siamo proteine accese da uno scopo, materia che anela al Senso.
Maria Popova vede nell’Amore la forza che ci spinge a sopravvivere a questo abisso: amore per la conoscenza, per il mistero, per la bellezza senza ambizione.
Ma forse hanno ragione Tolstoj e Lewis: l’amore non è la causa, è la conseguenza. La causa è la consapevolezza del divino in noi, che non può far altro che produrre amore verso tutto il resto.